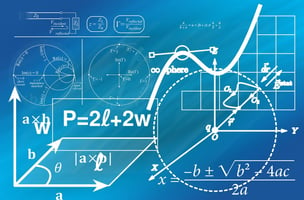I cambiamenti scaturiscono da fatti importanti spesso non generati dalla nostra volontà.
Gestire la complessità: dal caos al cambiamento consapevole
Introduzione
Viviamo in un’epoca in cui le organizzazioni non sono più chiamate a risolvere problemi “complicati”, ma a navigare nella complessità. La differenza è sostanziale: il complicato ha soluzioni prevedibili (pensa a una missione spaziale, difficilissima ma pianificabile), mentre il complesso vive di variabili imprevedibili e proprietà emergenti (come l’educazione di un figlio: non esistono manuali che garantiscano il risultato).
Per aziende e persone, la sfida non è più solo “fare bene le cose difficili”, ma imparare a danzare dentro l’imprevedibile.
Ed è qui che entra in gioco il mentoring: non come ricetta magica, ma come spazio di consapevolezza dove allenare ascolto, responsabilità e capacità di leggere il cambiamento senza esserne travolti.
La complessità come risorsa e non come minaccia
Come ha ricordato Nicola Urbino nel webinar, la legge di Ashby ci dice che “solo la complessità governa la complessità”.
Tradotto: non possiamo semplificare a forza la realtà, dobbiamo renderci noi stessi più ricchi, più variegati, più pronti.
E qui le persone sono la leva fondamentale: non per quantità, ma per eterogeneità. Gruppi diversificati – per età, competenze, provenienza, esperienze – hanno più chance di trovare soluzioni nuove.
In questo senso, l’inclusione non è moda, ma strategia competitiva. Accogliere differenze significa generare innovazione e, a cascata, migliori performance economiche. Non un “lusso etico”, ma un circolo virtuoso che conviene.
Per chi desidera approfondire, Harvard Business Review ha pubblicato un’analisi su come essere leader più efficaci proprio in contesti caratterizzati da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità (VUCA)
Complessità e mentoring: adultità e responsabilità
Nella mia esperienza di mentoring e counselling, noto che la vera sfida non è trasmettere contenuti, ma allenare adultità: la capacità di assumersi responsabilità, di riconoscere le proprie risorse e di trasformare l’incertezza in apprendimento.
Il mentoring diventa allora un luogo di “decontaminazione” dallo schema rigido del “Genitore” o dalle emozioni incontrollate del “Bambino” (per citare l’Analisi Transazionale), per restituire all’“Adulto” la lucidità di leggere la complessità con mente chiara e cuore aperto.
La formazione che cambia: dalla ricetta fissa alla cucina sartoriale
Lara Bianchi, responsabile di un’Academy aziendale, ha usato una metafora illuminante: se un tempo la formazione era come cucinare sempre la stessa ricetta, oggi è come preparare un intero menù per ospiti con gusti, culture e allergie diverse.
La formazione non può più limitarsi a fornire competenze tecniche “replicabili”: deve saper personalizzare, mescolare digitale e presenza, micro-learning e confronto reale, senza illudersi che un corso sia “la panacea”.
E qui i manager hanno un ruolo decisivo: non possono delegare la crescita delle persone solo all’ufficio formazione. Devono essere coach quotidiani, capaci di alimentare quella miccia che un corso può solo accendere.
Complessità e organizzazioni: dal singolo alla comunità
Come ha sottolineato Luca Martini, non basta concentrarsi sul singolo individuo: la vera sfida è guardare anche alla comunità organizzativa.
La complessità richiede sicurezza psicologica, cioè contesti in cui le persone possano esprimere opinioni e dissentire senza paura di ritorsioni. Non è “buonismo”, ma la condizione che permette ai gruppi di apprendere, innovare e non disperdere talenti.
Conclusione: 5 chiavi per trasformare la complessità in risorsa
La complessità non è un destino infausto, ma un’occasione di crescita. Perché diventi leva di cambiamento servono cinque scelte concrete:
-
Accogliere la diversità – più differenze = più possibilità di soluzioni.
-
Creare sicurezza psicologica – senza paura, le persone osano innovare.
-
Passare da contenuti a responsabilità – il manager come coach, il collaboratore come adulto.
-
Sviluppare soft skill dure – ascolto, visione, problem solving complesso, comunicazione.
-
Nutrire la cultura del senso – il lavoro non è solo compito, ma appartenenza e crescita.
Bibliografia essenziale
-
Ashby W.R., Introduction to Cybernetics, 1956.
-
Siegel D., La mente relazionale, Raffaello Cortina.
-
Damasio A., L’errore di Cartesio, Adelphi.